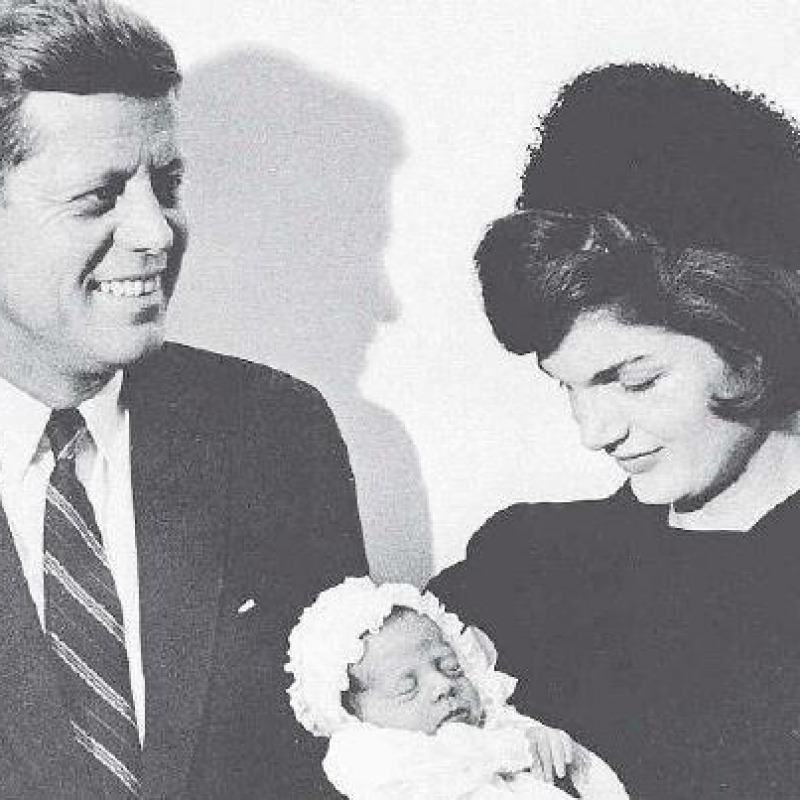
In uno dei film più memorabili del “maestro” John Ford spunta una frase a effetto, che fa capire al volo lo spirito e i valori della “frontiera” a m e r icana: “Qui siamo nel West, dove se si scontrano la leggenda e la verità vince sempre la leggenda”. Ne “L’uomo che uccise Liberty Valance”, un immenso James Stewart, il senatore Ransom Stoddard, cerca di raccontare ai giornalisti che non lui, ma un oscuro cow-boy, interpretato dal grande “Duke”, John Wayne, è il vero eroe del capolavoro fordiano. Niente da fare. Gli rispondono che non se ne parla proprio e che le cose vanno dette esattamente per come la gente vuole sentirle. Insomma, un Paese giovane come gli Stati Uniti, un calderone in cui bollono mille culture, ha bisogno di un carburante speciale per alimentare la sua ansia di crescere e per compattarsi. L’America è, soprattutto, un Paese senza storia. Per questo cerca disperatamente e in ogni momento di costruire le radici che non ha, aggrappandosi al “mito” e fabbricando eroi. E smentisce, clamorosamente, il pensiero che fu di Bertolt Brecht: “Sventurata la terra che ha bisogno di eroi”. Beh, gli Stati Uniti ne hanno bisogno. Come il pane. Washington, Lincoln, Franklyn Delano Roosevelt, tanto per citarne alcuni. E Kennedy. Lui, in un certo senso, e scusate l’irriverenza “s t orica”, forse li sintetizza tutti. In fondo, è stato un “generale” in tutti i sensi, proprio come Washington. Eroe di guerra e coraggioso stratega, con l’a i uto del fratello Bobby risolse la crisi di Cuba, andando contro i tre quarti della sua stessa Amministrazione, a cominciare dai ministri, per finire allo Stato maggiore militare al gran completo. Di Franklyn D. Roosevelt ha condiviso lo spirito dello statista che si confronta con un nemico forte e terribile. Che per il presidente del “New deal” fu senz’altro più il Giappone di Yamamoto che la Germania di Hitler. Per Kennedy, invece, si trattò di misurarsi con l’U n i one Sovietica di Krusciov e con un’Europa spaccata in due, da una Cortina di ferro e da un Muro, quello della “v e r g ogna”, che tagliava anche la capitale tedesca. Un monumento all’idiozia e all’ottusità delle dittature, che gli fece pronunciare, in un memorabile discorso, tenuto proprio a due passi dal Muro, la storica frase “Ich bin ein Berliner”, “Mi sento un berlinese”. Un appello a non sentirsi soli, un richiamo alla solidarietà della cultura occidentale e, contemporaneamente, l’i mpegno a non dimenticare la sofferenza di coloro che, a Yalta, avevano avuto solo la sfortuna di ritrovarsi nell’i mpero di Stalin, al di là della linea di demarcazione, freddamente segnata sulla carta geo grafica. Come Lincoln, John Fitzgerald Kennedy (JFK per ogni americano) si batté per i diritti civili, e per l’u g u a g l i a nza (quella vera) tra i cittadini, perché aveva capito che una grande nazione non si costruisce “contro” qualcuno, ma solo col decisivo contributo di tutti. Anche se, for the record, va sottolineato che il suo approccio al problema fu un tantino tiepido, forse perché i tempi non erano proprio maturi. Fu infatti il suo successore, Lindon Johnson, a siglare, nel luglio del 1964, il Civil Rights Act. Vietnam. Benchè JFK sia stato quasi sempre associato, correttamente, a una politica di distensione, la strategia del “containment” lo obbligò ad assumere una posizione molto dura nel sud-est asiatico, che finì per aprire la strada a una rovinosa escalation. Come Abramo Lincoln venne assassinato. Esattamente cinquant’anni fa, in un soleggiato mattino di novembre, a Dallas, Texas, in uno dei tanti viaggi organizzati affinché il suoi “Stati” fossero veramente “Uniti”. E perché il dovere di ogni buon presidente non è solo stringere le mani dei suoi compatrioti, ma anche quello di toccare i loro cuori e fare di tutto per entrarvi. Ma oggi non vogliamo rievocare i dettagli di quell’o s c uro omicidio, su cui sono stati versati fiumi d’inchiostro e sul quale commissioni d’inchiesta di tutti i generi possibili, a cominciare dall’arci-famosa (o famigerata) Warren, non sono riuscite a tirare fuori un ragno dal buco. Apparteniamo, tanto per essere più chiari, al partito dei “complottisti”, come vengono definiti coloro che non credono sia stato solo Lee Oswald a sparare. Anzi. Siamo convinti che nella “sporca faccenda”, quando si scaverà a fondo (forse tra un secolo) c’entrassero in molti. Fino al collo. L’origine? Più America che Urss, tanto per capirci. O forse tutte e due. Letture di report, “carte” declassificate dalla Cia, interviste e spifferi a mezza bocca, ci portano a pensare che Kennedy abbia pagato il repulisti fatto proprio alla Central Intelligence Agency dopo la tragicomica mini-invasione di Cuba, tentata alla Baia dei Porci, per fare la festa a Fidel Castro. Una passata di spazzole che non ha risparmiato nemmeno l’Fbi. E sempre Cuba c’entra quando si parla del destino dei Kennedy. Dato che anche a Robert (Bobby), la vera eminenza grigia della famiglia, l’hanno fatta pagare salata qualche anno dopo. Durante la crisi dei missili (1962) i due fratelli si misero contro tutti: dal Ministro della Difesa McNamara ai capoccioni del Pentagono. Tennero duro ed evitarono, fino all’ultimo, di premere il grilletto, che forse avrebbe fatto precipitare il pianeta nell’abisso. Vinsero (anzi, abbiamo vinto tutti), ma i militari gliela giurarono. Per inciso, Bobby era Ministro della Giustizia, e qualche analista sostiene che le disgrazie dei Kennedy fossero anche legate alle promesse (non mantenute) che sarebbero state fatte alla mafia, nel corso della tiratissima campagna elettorale, contro Nixon, per la Casa Bianca. Ma, secondo noi (e non solo), la mafia sta all’omicidio di JFK come il timoniere sta al capitano di una nave. Mantiene la rotta dettata da un altro. E John Kennedy stava sullo stomaco a parecchi “capitani” del transatlantico Usa. Forse non era odiato quanto Bobby, ma in quel momento il presidente era lui, e aveva il “difetto” di farsi consigliare dal fratello anche quanto ketchup mettere sugli hamburger. Insomma, ci siamo capiti: Bobby pensava e John rifletteva. Ma poi aveva il pregio di scegliere (quasi sempre) quello che gli suggeriva il suo “hermano”, svelto di lingua e di neuroni. Se questa equazione è corretta, ne discende un’altra importante. Il “vero” presidente, nei frangenti più delicati, è stato Bob. Proprio per questo non sarebbe mai potuto diventare il “presidente vero”. Chi ha ucciso JFK conosceva tutto il suo valore e, inoltre, sapeva benissimo che, se fosse entrato alla Casa Bianca, il giovane Kennedy avrebbe messo sottosopra gli archivi del governo e quelli dei servizi segreti. Per arrivare alla verità e alle menti del complotto. Non glielo permisero e un cane sciolto gli sparò alla nuca in un albergo di Los Angeles, mentre faceva campagna elettorale per la Casa Bianca. Così il più brillante dei Kennedy morì, ma gli sopravvisse il “mito”. Quello del fratello JFK. Ha scritto Auden nella sua elegìa dedicata a John: Why then, why there? Perché allora, perché lì?/ Why thus, we cry, did he die? Perché così? Piangiamo, è morto?/ The heavens are silent. I cieli sono muti…What he is fated to become, ciò che egli è destinato a diventare/ Depends on us. Dipende da noi”... E così torniamo all’inizio della nostra riflessione. Il mito che diventa leggenda e si sublima nella storia, come nei film di John Ford, che incarnavano e diffondevano tutti gli ideali della “frontiera”. Un eroe dei tempi moderni John Kennedy, un totem al quale l’America ha ancora un disperato bisogno di aggrapparsi. Per riconoscersi. Un “presidente vero” ucciso prima di Bob. Il “vero presidente”.









Caricamento commenti