
Dal minimalismo alla pop-art: l'intero percorso artistico di Lucio Fontana è raccontato nella grande retrospettiva che si apre domani al Museo di arte moderna di Parigi. In mostra fino al 24 agosto sono riunite per la prima volta 210 opere, con prestiti provenienti da musei e gallerie di tutto il mondo, in particolare dalla Fondazione Fontana e dal Centre Pompidou che nel 1987 aveva ospitato l'ultima rassegna francese dedicata all'artista italiano, nato nel 1899 a Rosario in Argentina e trasferitosi da bambino a Milano dove ha trascorso il resto della sua vita.
"Fontana ha due voci - spiega Sebastien Gokalp, uno dei curatori assieme a Choghakate Kazarian -: una pura, semplice, quella dei 'tagli', dello 'spazialismo'; e l'altra barocca, fatta di materia, movimento del gesto, proliferazione di segni. Questi due aspetti sono sempre presenti in Fontana".
La rassegna parigina vuole fare conoscere un Fontana a tutto tondo che non si riduce ai suoi famosi tagli. "Abbiamo voluto fare qualcosa di nuovo, apportare un tocco di novità e quel di più erano appunto i rapporti di Fontana con il design pop e l'architettura, le ceramiche e i video - prosegue Gokalp - Volevamo mostrare tutti questi aspetti costitutivi di un unico puzzle e necessari alla comprensione della sua opera".
Quindi Fontana è un pop-artist come si intuisce anche della copertina del catalogo? "Fontana può essere considerato un artista pop, al pari di Roy Lichtenstein e Andy Warhol - osserva il curatore - : negli anni Sessanta fa un lavoro molto più in sintonia col suo tempo. I 'Teatrini', sono rappresentazioni barocche dai colori vivi, gli oggetti sono laccati, negli 'olii' si passa dal verde elettrico al rosa shocking.
In questo senso diciamo che Fontana è pop". Il percorso espositivo è cronologico e si sviluppa in 14 sezioni: si comincia dal primitivismo degli anni Trenta, che definisce un nuovo stile figurativo, con al centro della sala la scultura in bronzo del 'Fiocinatore'; passando per le sculture astratte e le ceramiche (Fontana aderisce al movimento di avanguardie europeo Astrazione-Creazione) fino alle visioni barocche e alla fondazione dello Spazialismo (1946-1952) con una teoria della spazialità rivoluzionaria che si traduce nel superamento dei generi tradizionali (pittura, scultura, poesia, musica) in una sintesi tra "colore, suono, movimento, spazio". Nel 1949 la tela diventa diventa il suo supporto preferito: c'è il ciclo dei 'buchi', fori realizzati sul davanti o sul rovescio, in modo da costruire diverse figure; quindi la serie dei 'tagli', intitolati 'Concetto spaziale' e 'Attesa' o Attese' se costituiti da più fessure. "Ho inventato una nuova formula, oltre non potrò andare", spiegava l'artista, per il quale il taglio o il buco "non era la distruzione del quadro ma una dimensione al di là del quadro, la libertà di concepire l'arte attraverso qualunque forma".
E poi ci sono i suoi contributi in architettura, dal modello del soffitto di neon a 'Italia 61' a Torino al bozzetto per la porta del Duomo di Milano. Quindi le 'Nature', gli "Ambienti", gli "Olii" con i colori della pubblicità e dell'industria, le "Venezie" con le schegge di vetro di murano e i "New York" in metallo. In conclusione ci sono le serie di 'Fine di Dio', tele monocrome di dimensione umana bucate, simbolo "dell'infinito, della fine della figurazione, del principio del nulla". E i Teatrini dell'ultimo periodo dall'estetica pop: cornici in legno laccato, con sagome di natura, arabeschi barocchi, forme fluttuanti e paesaggi. Da non perdere alcuni video inediti che ritraggono Fontana all'opera tra cui quello prestato dalla Galleria Tornabuoni Art sulla realizzazione di 'Le Jour (1962).





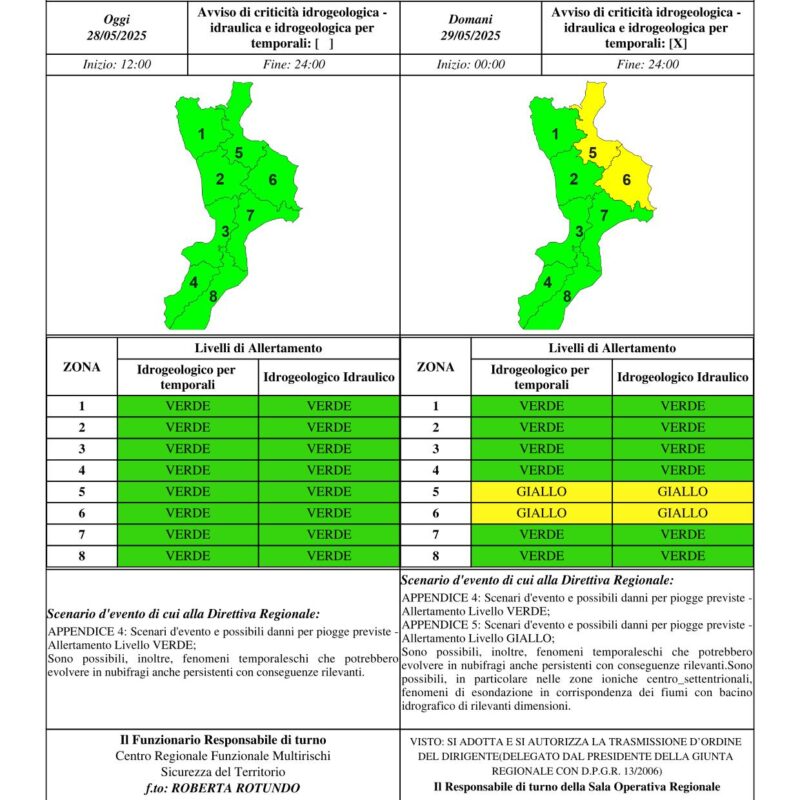

Ancora nessun commento