
Ardea, 509 a.C., una sera d’inverno, apparentemente qualunque, di un assedio che ormai si prolunga da tempo. Finita la cena, i figli di Tarquinio il Superbo e il loro cugino, Tarquinio Collatino, si abbandonano ai piaceri del vino e della conversazione; finché questa non cade sulle mogli, trasformandosi in una sorta di contesa su chi abbia quella più virtuosa. Resi audaci dall’ebbrezza, i giovani decidono di uscire di nascosto dal campo e di verificare di persona, cogliendo di sorpresa le spose. Giunti a Roma, trovano le principesse immerse in spensierati banchetti; poi puntano sul piccolo borgo di Collazia, dove la scena che si presenta ai loro occhi è ben diversa: la moglie di Collatino, Lucrezia, siede nell’atrio circondata dalle sue ancelle, intenta a filare la lana alla luce di un’esile fiaccola.
È l’attività per eccellenza della perfetta matrona, quella che le è stata riservata fin dalle leggi di Romolo e che compare sulle tombe a ricordarne i meriti: «Custodì la casa, filò la lana», un epitaffio che condensa il senso di un’intera esistenza. Collatino, pertanto, ha vinto la sfida, ma il prezzo di tale vittoria è la vita stessa di Lucrezia. Mosso dalla bellezza della giovane – e probabilmente anche da un sentimento di rivalsa – Sesto Tarquinio, uno dei perdenti, torna a Collazia e abusa di lei. Per non sopravvivere all’onta, Lucrezia si uccide; il suo atto innesca una rivolta popolare che porta al rovesciamento della monarchia e all’istituzione della repubblica. È questa storia antica l’oggetto della riflessione del bel libro del prof. Mario Lentano, docente di Lingua e letteratura latina all’Università di Siena, “Lucrezia. Vita e morte di una matrona romana” (Carocci), che ci piace recensire oggi, a ridosso della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne: un racconto di grande significato civico per i Romani, poiché immortala un cambiamento storico epocale, ma anche di grande valore etico, perché propone un modello di donna, centrale nel sistema valoriale di quella civiltà, che percorre tutta la storia della cultura latina, passando indenne anche dal crivello del cristianesimo: quello della casta matrona, capace di sacrificare la sua stessa vita alla fedeltà coniugale.
Non un racconto qualsiasi, dunque, ma piuttosto un “mito”, perché di mito si può parlare, spiega Lentano, per «un racconto nel quale un’intera cultura ha riconosciuto per secoli alcuni contenuti fondanti della propria identità». E questo spiega come mai, a dispetto dei pochi giorni in cui si consuma, la vicenda sia stata capace di attraversare i secoli, ispirando incessantemente la letteratura e le arti figurative, dagli autori latini a Simone de Beauvoir, dai cassoni per il corredo di spose benestanti a Guido Reni, passando attraverso altri nomi famosi: il Sodoma, la cui Lucrezia campeggia nella copertina del libro, il Parmigianino, Tiziano, Tintoretto, Rubens.
Le fonti superstiti non tramandano nulla della vita di Lucrezia, al di fuori dell’arco di tempo che intercorre tra la notte maledetta in cui il figlio del Superbo se ne invaghì e il suicidio, ovvero il tempo in cui la sua esistenza privata interseca la grande storia di Roma. Non sappiamo neppure quale fosse il suo aspetto, anche se le fonti antiche ne ricordano la bellezza e Ovidio ne declina i tratti secondo i canoni tradizionali: la carnagione bianchissima, i capelli biondi, l’assenza di qualunque artificio. Non sappiamo quale età avesse, anche se doveva essere giovanissima: a Roma una donna andava in sposa già a dodici anni, non appena fosse viripotens, «in grado di reggere un uomo», così da adempiere alla sua unica funzione sociale, quella della procreazione. E Lucrezia non aveva ancora avuto figli.
Ci potrebbe pertanto stupire il sottotitolo di questo libro, se non fosse che Lentano trasforma l’icona in donna, ricostruendo, grazie alla sua profonda conoscenza della storia e della cultura romana, «quella che fu, o avrebbe potuto essere», la storia di Lucrezia. Così, dopo un prologo di taglio spiccatamente narrativo, in cui sono raccontati i fatti che portarono Sesto Tarquinio a casa della donna la notte in cui si incapricciò di lei, la sua scrittura ci conduce nell’interno di un’agiata casa romana in cui una neonata sta venendo al mondo, facendoci vedere e sentire i personaggi che si muovono attorno alla partoriente, per poi accompagnare la bambina fino al giorno delle nozze, lasciandocela ammirare, sull’uscio della sua nuova vita, avvolta nel velo rosso delle spose del tempo, mentre stringe un mazzetto di maggiorana.
Ma anche quando guarda alla Lucrezia storica Lentano lo fa cercando, dietro l’icona, la donna. Lo fa interrogandosi, alla luce della biologia e della giurisprudenza del tempo, sulle implicazioni oggettive dello stupro, che sono poi la chiave di lettura per comprendere appieno il significato dell’atto di Lucrezia. Lo fa ricostruendo, alla luce dei dati storici e delle convenzioni sociali del tempo, il mondo maschile che interagisce con lei e ne condiziona la sorte, da Sesto Tarquinio, che le fa violenza, a Collatino, che a quella violenza, pur involontariamente, la espone, a Bruto, che ne fa esibire il cadavere «in tutta la sua violata sostanza carnale» al fine di aizzare la rabbia popolare, dimenticandolo, una volta ottenuto lo scopo. Lo fa citando la lettura revisionista di Agostino, che vede nel suicidio il segno di una sua possibile colpevolezza: perché – dice – chi è innocente non si macchierebbe di colpa uccidendosi.
Il libro di Lentano offre molti spunti di riflessione, toccando temi attuali. In particolare, ci fa riflettere su che cosa significhi «nascere femmina» in un mondo che sancisce la sottomissione della donna all’uomo non solo nelle sue norme e nelle sue formule giuridiche (compreso il fatto che le donne erano prive di un nome proprio, derivandolo dal gentilizio del padre), ma persino nei nomi dei suoi dèi “dell’attimo” (tra quelli che presiedevano all’unione sessuale, Subigo e Prema, legati a verbi che significano «sottomettere» e «schiacciare»). Ci mostra che cosa vuol dire vivere in una società in cui l’unico statuto della donna è quello di madre, e in cui una donna che ha subito violenza, dal momento che non può più trasmettere puro il sangue della stirpe è, prima ancora di morire, “un cadavere sociale”. Ci insegna che la trasformazione della vittima in imputata, vergogna dei processi moderni per stupro, l’ha praticata per primo Agostino, che la riduzione della donna a corporeità è un retaggio culturale antichissimo, del quale ancora non riusciamo a liberarci.
Il 25 novembre scorso, nei maxischermi digitali che Urbanvision gestisce nelle grandi città i messaggi pubblicitari sono stati sostituiti dai nomi di tutte le donne uccise in Italia con la data della loro morte e il modo in cui sono state assassinate. Ne mancava uno, lontanissimo nel tempo: Lucrezia, 509 a.C. Uccisa da una cultura che, persa la sua pudicitia, non le consentiva altro che morire.
Anna Maria Urso, Professore associato di Filologia classica e Drammaturgia classica, Università di Messina

Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.






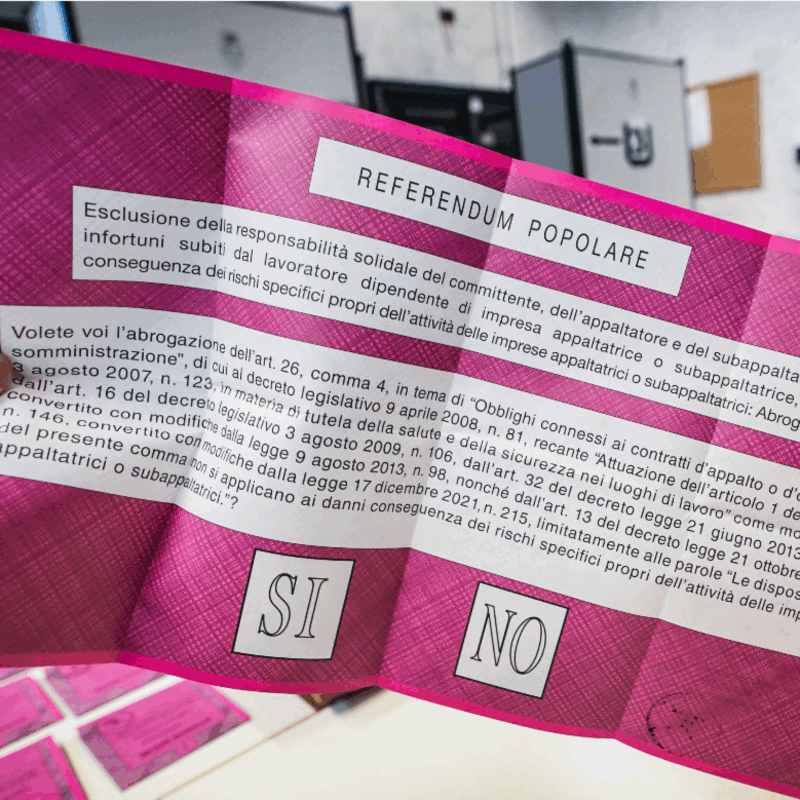



Ancora nessun commento