E sì, c’eravamo. Eravamo lì, in quella notte di più d’un secolo fa quando il tempo si fermò. Una notte che tutti conosciamo, attraverso i racconti familiari e la mitologia condivisa, una delle più forti e persistenti delle comunità strettesi. Una notte che la “stanza immersiva” della mostra permanente «1908 CittàMuseoCittà», aperta da oggi al pubblico al Museo Interdisciplinare Regionale, nei locali dell’ex Filanda Mellinghoff, fa rivivere in ogni dettaglio.
Lì, al MuMe – che non è una raccolta di resti ma un racconto vivente delle città morte che si sono succedute nei luoghi in cui noi viviamo oggi – nel mezzo dei percorsi e dei reperti e delle narrazioni che s’incrociano, la tecnologia compie l’ennesimo miracolo, e restituisce vita e movimento e profondità e suono ed emozione al racconto, al ricordo. Come recita lo stesso titolo, vuol essere una simbolica “restituzione” della città alla città: un’operazione di futuro.
In qualche modo, quella stanza “immersiva” è il cuore della mostra, che pure è tutta strutturata sul dialogo tra le più moderne tecnologie e le vestigia del passato. Diciamo che a chi lo conosce bene (e chi non lo conosce può approfittarne, e non perdersi più a lungo un’esperienza così forte e importante) il MuMe è assai caro proprio per questo, per la sua qualità di macchina viva della memoria, di laboratorio di appartenenza e cittadinanza. Aperto nella sua completezza dopo anni e anni (appena nel 2017), col doppio mandato d’essere museo e dunque conservare, ma esserlo in un luogo più e più volte distrutto, il cui “corpo” è stato variamente disperso, il MuMe è stato costruito in modo innovativo, e la volontà di dialogare con la città e col tempo presente in tutte le forme possibili – dalla scelta dei percorsi espositivi agli eventi, alla qualità delle esposizioni – è nel suo corredo genetico, ma è anche missione alla quale aderisce con entusiasmo il direttore Orazio Micali, che della mostra è il curatore.
E quel segmento mancava. L’ultima delle opere esposte nelle sale del Museo è del 1907, sull’orlo della distruzione, della voragine, dell’ “epoché”. Subito prima di quella notte – tra il 27 e il 28 dicembre 1908, alle 5,20 e 27 secondi (nella sala immersiva ci appare, in un interno borghese che s’affaccia sulla città, una pendola al muro, con la lancetta che avanza, avanza…) – che ha avuto una doppia, e singolare, conseguenza: fissarsi indelebilmente nella memoria di tutte le generazioni a venire eppure essere alla base d’un gigantesco alibi, quello della “cancellazione” della memoria che giustificherebbe la decadenza d’un intero territorio. In realtà, sono vere entrambe le cose: un’enorme e distruttiva cesura della storia delle comunità dello Stretto, eppure un evento fondativo dell’identità degli Strettesi.
La mostra ci dice con chiarezza cosa abbiamo perduto: la sfavillante policromia dei marmi, la bellezza dei capitelli, delle colonne, delle statue ci parlano non solo dell’aspetto magnifico della “città delle cento chiese”, ma del lavoro di maestranze specializzate, della raffinatezza delle committenze, dell’economia di quello che era il quinto scalo italiano. Una città di scambi, d’incroci, di movimenti, di cultura, di talenti. Notizie che un primo breve video racconta, nell’escalation di tecnologia che costruisce l’ossatura della mostra: l’audiovisivo, la realtà aumentata, la realtà virtuale immersiva (col lavoro d’un eccezionale, e giovane, team e di Capitale Cultura Group / ARtGlass).
I reperti sono scelti con sapienza: tra essi la testa d’aquila coronata, l’assorta «Madonna della Misericordia (o del latte)», gli «Angeli» d’Innocenzo Mangani che sembrano dialogare, la parete mozzafiato di lastre variopinte di marmo provenienti dalla distrutta Chiesa di San Gregorio. E poi l’arte strappata e mutila, i dipinti danneggiati, dai crocifissi più antichi alle «Accademie di nudi» settecentesche di Letterio Paladino: il Museo come luogo in cui si conservano, si mostrano anche le ferite. Un racconto che prosegue attraverso i documenti, illustrazioni e locandine: il lavoro per ricomporre gli archivi è parte della conservazione, come sottolinea con grande partecipazione il direttore Micali, che ci ha fatto da cicerone nella prima visita, attento a mostrare il lavoro incessante del Museo, perché conservare è programmare e agire, dare un posto alle cose vuol dire ricostruirne per intero peso e presenza e percorso.
Ma l’immagine della città perduta non è affidata soltanto ai suoi, pur magnifici, frammenti. Indossando il visore (che non è “oscurante”, ma consente di mantenere la visione dell’ambiente attorno) e gli auricolari e “puntando” sei dei reperti in mostra si può, letteralmente, passeggiare dentro il centro della Messina sparita, di cui il prodigioso team tecnico ha ricostruito in ogni dettaglio il tessuto urbanistico e architettonico (le mattonelle del selciato, le aiuole, le insegne delle botteghe), e pure, sempre rigorosamente basandosi sulle immagini d’epoca, le figure dei cittadini, lavoratori o passanti. Perché, come ha chiarito l’amministratore delegato di Capitale cultura, Antonio Scuderi, «se non c’è profondità della ricerca, il digitale è un guscio vuoto». E di ricerca dietro questa mostra ce n’è tanta (e non finirà qui: «Stiamo già lavorando alla crescita dei contenuti, al potenziamento delle sezioni, all’inserimento di ulteriori tecnologie pensando anche alle scuole e alle generazioni più giovani», ha detto Micali, e la consideriamo una promessa).
Dopo il percorso in sei tappe che consente d’aggirarsi dentro il cuore della città ancora intatta, alla “stanza immersiva” viene affidato il compito di riportarci lì, a quella notte. Cominciando con le musiche dell’Aida, che quella sera fu rappresentata al Teatro Vittorio Emanuele e che in qualche modo fa da sfondo e premessa sonora, con la sua bellezza preveggente: i protagonisti muoiono sepolti vivi, come accadde davvero al tenore astigiano Angelo Gamba, che con la sua intera famiglia fu tra le centomila vittime (e di cui si racconta avesse intonato l’aria «O terra addio» prima di morire, ma questa sembra tanto una delle numerosissime leggende che accompagnano il terremoto del 1908, che fu, come ogni catastrofe, anche una formidabile occasione mitopoietica). L’ “immersione” avvolgente nella città, che precipita dalla quiete notturna allo sconvolgimento e crolla in macerie nei suoi luoghi-simbolo, con una colonna sonora ad alto impatto, ha un fortissimo potere evocativo. E m’ha fatto pensare a un’altra opera mirabile e recente, il romanzo “Trema la notte” (Einaudi) in cui la scrittrice messinese Nadia Terranova compie un’operazione simile: restituire, con la narrazione, la memoria, ricomporre la trama spezzata, descrivendo lo sconvolgimento di quella notte ma soprattutto il suo “dopo”.
Il “dopo” che troviamo nelle sale successive, di cui una in particolare, che costituisce un’installazione artistica più che un’esposizione di reperti. Sono i resti di marmo e pietra di angeli, putti, bambini, raccolti tutti assieme, confusi, ammassati come vittime (e la contemporaneità d’immagini di vittime della guerra così ammassate crea un perturbante cortocircuito col nostro presente).
«Vittime», mormoriamo infatti, girando attorno a quella scultura fatta di sculture ferite. Ed è lì che il MuMe raggiunge il suo scopo, che è di questa mostra ma è di sempre: sentiamo la ferita della memoria come ferita della carne, ci tocca con forza inaspettata. E non la dimenticheremo.






















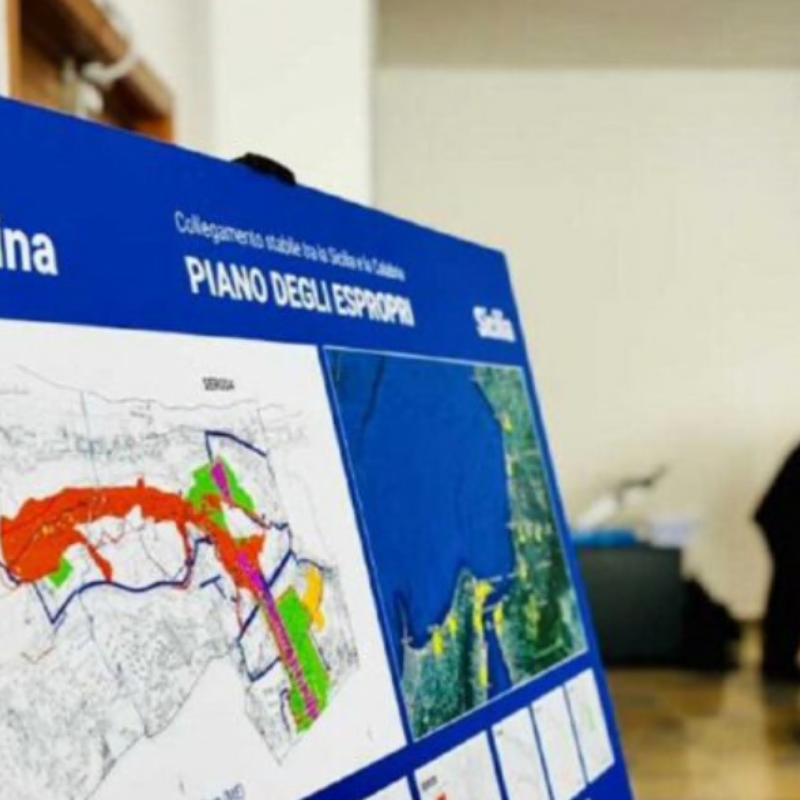

Ancora nessun commento