
Il corposo studio sociologico sugli italiani del New Jersey meridionale di Emily Fogg Meade, realizzato agli inizi del Novecento e ora miracolosamente recuperato e tradotto in Italia, “Immigrati italiani in America. Hammonton NJ, 1907” (Pungitopo, traduzione a cura di Francesca La Maestra) va letto ed esaminato per almeno due ragioni. La prima è la grande quantità di dati economici, finanziari, sociologici, culturali, politici, in grado di disegnare un profilo sintetico e approfondito dell’italiano migrato negli Usa. La seconda ragione riguarda la formidabile affinità tra quella piccola realtà americana, Hammonton, e l’attuale stato della riflessione italiana sulla migrazione contemporanea. Quello della sociologa americana è il classico studio nordamericano basato su dati concepiti come oggettivi: al primo posto i dati dell’economia, la capacità lavorativa, la trasformazione dell’immigrato in forza lavoro flessibile e adattabile alle esigenze del sistema statunitense; l’agricoltura come base dell’insediamento, l’industria come prospettiva, l’artigianato come cuscinetto tecnico e professionale; le dichiarazioni delle tasse come misurazione della ricchezza. Al secondo posto le relazioni sociali basate sui matrimoni e sui figli medi per coppia, sul ruolo della donna nella comunità, sui reati frequenti. Quindi la cultura misurata sul consumismo, sul vestiario, sull’alimentazione e ogni altro aspetto della vita comunitaria.
Il tratto caratteristico dell’analisi è il lodevole tentativo di dimostrare che i pregiudizi che allora, nel 1907, le autorità e la popolazione americana di nascita nutrivano nei confronti degli italiani erano infondati. Fogg Meade è sempre alla ricerca di dati che dimostrino che, nonostante il furto fosse «il reato più diffuso fra gli italiani, che hanno anche la tendenza a mentire frequentemente», la causa fosse da ascriversi alle condizioni di povertà. Per cui bastava che cambiassero le condizioni economiche perché svanissero questi comportamenti socialmente riprovevoli. Poiché i pregiudizi sugli italiani erano tantissimi, la sociologa spende duecento pagine per controbattere ogni aspetto stereotipato.
Ora, la sorpresa sta nella somiglianza tra quella costruzione culturale di pregiudizi e la costruzione culturale e, potremmo aggiungere, politica che oggi in Italia si fa nei confronti dei migranti, soprattutto quando provenienti dal continente africano o dal Medio Oriente. Ora, così come avrebbe dovuto essere allora negli Usa – e non fu – la risposta non è la formulazione di una teoria integrazionista (da melting pot, per intenderci), poco convincente sul terreno dei processi storici e sociali. Lo sforzo che l’autrice compie, di ricomprendere dentro una cornice integrata ogni “diversità”, finisce per esaltare, paradossalmente, proprio la “diversità”, che vorrebbe sterilizzare.
Tuttavia, Fogg Meade in un capitolo dedicato alla seconda generazione trova una chiave di analisi innovativa e interessante. Infatti, per spiegare insuccessi scolastici e ritardi nell’apprendimento dei giovani italiani esamina le loro condizioni di vita difficili in America e non come portato dell’eredità culturale dei luoghi di provenienza. «Nella scuola, come risultato della segregazione degli immigrati di varie nazionalità, i bambini italiani possono venire ammassati tutti insieme o con bambini di altre nazionalità e il loro inglese è un dialetto di bassifondi, un misto di espressioni gergali e di inglese scorretto e sgrammaticato. La pressione della vita di città comporta il precoce abbandono della scuola da parte dei bambini che sono costretti ad andare a lavorare». In sostanza, sono le condizioni di vita del Paese di accoglienza che determina situazioni di svantaggio, indipendentemente dal retaggio delle origini, come altre volte sembrerebbe.
L’interesse per lo studio di Emily Fogg da parte dell’editore messinese Pungitopo e di Marcello Saija, che ha curato la preziosa introduzione, non riguarda soltanto il racconto di una esperienza storica di siciliani in America. Riguarda anche il riferimento a una catena migratoria proveniente dal villaggio di Gesso. Come riferisce l’autrice, nel 1866 da Gesso partì Matteo Campanella, che giunse per vie complicate a Hammonton. Matteo nel 1870 chiamò il fratello e, a seguire, parenti e amici dello stesso villaggio: «Come risultato di una continua migrazione da Gesso, più di metà degli abitanti di quel villaggio sono negli Stati Uniti e molti di loro vivono ancora a Hammonton». Grazie alla chain migration, uno zio dei Campanella, Peter Raneri, e un cugino, Antonio Capelli, cominciarono ad acquistare terreni e misero in piedi imprese.
Il volume, così, si arricchisce di un’Appendice costituita da tre saggi, di Federica Cordaro, Mario Sarica ed Eugenio Campo, che da tre punti di vista diversi esaminano il percorso “Gesso - Messina - Hammonton (New Jersey) solo andata”. Tre testimonianze che assorbono nella storia vera i riflessi mondani causati dalle origini della moglie del nuovo Presidente Usa Biden, Jill Jacobs, rendendo tutto più comprensibile.
Il capitolo dedicato al “Tenore di vita”, in assoluto il più interessante dal punto di vista antropologico culturale, prende Gesso come termine di confronto per misurare le differenze tra la Sicilia e gli Usa: «Gesso, tipico villaggio siciliano, distante 6 miglia da Messina, appollaiato sulla cima di un monte, è il luogo da cui si sono staccati gli immigrati siciliani venuti a Hammonton. Lì gli abitanti vivono ammassati nello spazio di un piccolo villaggio lungo mezzo miglio e largo un quarto di miglio, attraversato in tutta la sua lunghezza da tre strade. Tutto lo spazio in cui sia stato possibile costruire, è ricoperto da case di mattoni di tre o quattro stanze, una delle quali è adibita a stalla per il mulo; vi vengono tenuti anche polli e maiali… Gli abitanti del villaggio posseggono piccole proprietà… I mercati in cui vengono portati i prodotti sono poveri e i contadini ne ricavano guadagni molto magri… La vita, per contro, è poco costosa… dato che il cibo – quasi completamente privo di carne – è economico… Il vestiario costa poco ed è piuttosto rozzo». Un’immagine impietosa della Sicilia del tempo, fondata sulle testimonianze degli immigrati.
Qual era l’impatto di questi resoconti sulla opinione pubblica americana? Certamente pregiudizi e riserve aumentavano e il profilo tendeva verso lo stereotipo, il luogo comune. Questa banale considerazione dovrebbe indurci, oggi, a pensare meglio alla narrazione con la quale accompagniamo i flussi contemporanei di mobilità demografica globale. Narrazione non solo e non sempre della parte dell’opinione pubblica contraria a tali flussi, ma anche della parte favorevole, sensibile ai processi di integrazione. Interessante è anche il colpo inferto da Emily Fogg al cosiddetto buon gusto del made in Italy: «Uno dei rilievi più frequenti che vengono mossi agli immigrati italiani – scrive – è il fatto che, costretti dalla povertà a mantenere a lungo un tenore di vita misero, non lo migliorano una volta che hanno migliorato la loro condizione economica». In fondo, sostiene la sociologa, gli italiani hanno una marcata caratteristica, quella di essere frugali, sempre, sia da poveri, sia da ricchi. Uno spaccato storico, sociologico e antropologico, quello tracciato da Emily Fogg, che va letto, digerito e assimilato, con lentezza e con leggerezza.








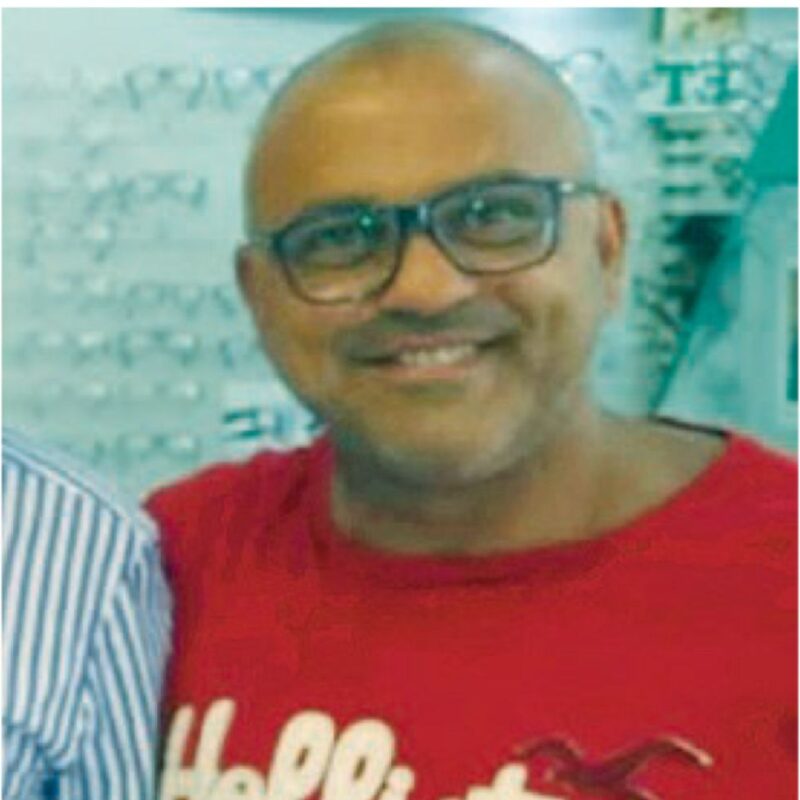
Ancora nessun commento